Settimana dell’educazione 2023
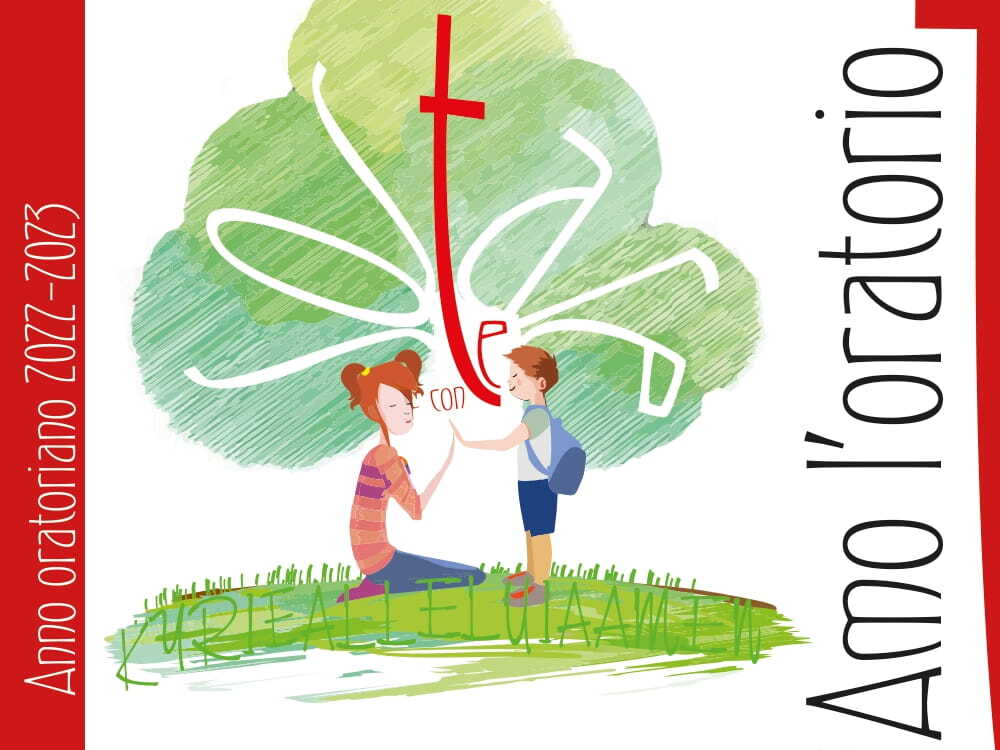
“Proponiamo che il filo conduttore della Settimana dell’educazione 2023 sia un pensiero sull’oratorio che ponga l’attenzione sulla vita dei ragazzi e delle ragazze – tutti, nessuno escluso –; su come essi vivono la fede e l’esperienza del crescere, nel contesto in cui abitano, in relazione con i loro pari, in rapporto con le figure educative, i genitori, gli adulti, la comunità; su come vivono i loro impegni di studio e di sport; su come abitano il loro tempo, esercitano la loro libertà, utilizzano i social, interpretano la loro corporeità e la sessualità; vivono situazioni di disagio, di povertà o dolore.”
Riprendiamo qui il tema del tipo di pastorale, come riportato sul documento “PensiAmo l’oratorio” del 2022 redatto dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi).
Quale tipo di pastorale ospitale e missionaria per gli oratori oggi?
Innanzitutto, una pastorale svuotata di pesantezza formale che immobilizza le energie dietro a troppe chiusure e blocchi. Oltre i formalismi, c’è la gioia dell’incontro e della relazione, soprattutto della relazione educativa dello “stare in mezzo”; c’è il farsi carico gli uni della vita degli altri; c’è la logica della fraternità. Nella progettazione educativa occorre lavorare, quindi, su ciò che riempie di gioia la vita dei ragazzi e la scuote, orientandola al bene; occorre lavorare tanto sul mettere in relazione le persone, facendole incontrare, chiedendo loro di mettersi all’opera in azioni buone e incisive, perché accanto al “fare per”, all’agire (che è diverso dal fare per fare) si generino e alimentino amicizie e alleanze. La pastorale degli oratori, vista nella sua forma missionaria, abbandona la logica dell’arruolamento di pochi per inquadrarli subito in un ruolo istituzionale, incasellandoli in un elenco, e accoglie la logica dell’invio a molti, a tutti, come destinatari primari, in analogia alla folla del Vangelo. La riduzione numerica della compagnia ecclesiale non autorizza nessuno a trasformare l’oratorio in una tana. La pastorale di missione è la forma matura della pastorale di adesione. I pochi non sono mai autorizzati a trascurare i molti. I pochi dovranno essere aiutati a considerare sempre i molti come la naturale destinazione della loro testimonianza di fede.
Aprendoci a tutti abbiamo bisogno di pensare l’oratorio come un sistema che si integra con altri. Chi è chiamato in esso a evangelizzare e a educare costruisca per se stesso una solida identità, alimenti la sua fede, abbia chiari i suoi riferimenti e poi si apra al mondo con fiducia, non avendo come priorità il presidio ma l’invio e il mandato. L’oratorio non è un erogatore di servizi, ma uno dei cuori pulsanti della Chiesa che annuncia il Vangelo, senza arroccarsi in posizioni di esclusione né tantomeno nei suoi spazi. L’oratorio avvicina gli estremi perché conosce la complessità della vita dei ragazzi e delle famiglie a cui va incontro. L’oratorio per questo non può mai prescindere dal proprio contesto. Il confronto con il proprio contesto umano, territoriale, civico, culturale, sociale è il primo fondamentale criterio di funzionamento di un oratorio. L’oratorio non è mai un progetto pastorale chiuso, ermetico, impermeabile. È modalità dinamica di presenza della Chiesa nel territorio. L’oratorio non potrà praticare l’ospitalità, per cui è stato inventato, se non in relazione alla vita delle persone a cui è stato mandato. È questa vita così complessa, che per la maggior parte del tempo si gioca “là fuori”, che l’oratorio deve imparare sempre più ad abitare. Per questo abbiamo deciso di pensare l’oratorio e di ripensarlo di nuovo, abitando nuovamente questo tempo con lo slancio e la speranza del Vangelo.
(Tratto da: PensiAmo gli oratori, FOM, 2022)
